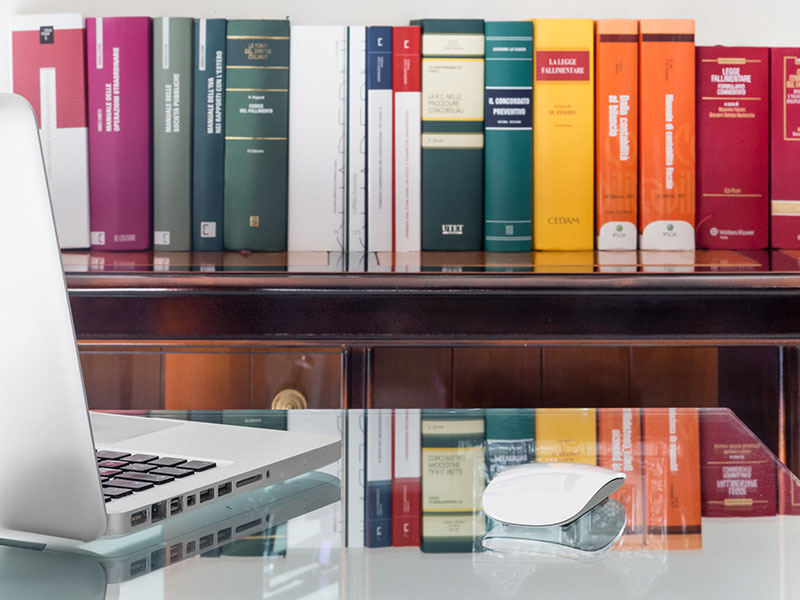L’impresa titolare di un credito verso un soggetto dichiarato fallito oppure – dal 15 luglio 2022 – assoggettato alla liquidazione giudiziale, ed eventualmente ammesso allo stato passivo esecutivo (per le procedure aperte dal 26 maggio 2021 l’insinuazione non è più necessaria per l’emissione della nota di variazione IVA ai sensi dell’art. 26, co. 3-bis, lett. a), del D.P.R. 633/1972), deve prestare particolare attenzione all’importo da iscrivere in bilancio, ancorché nella prassi contabile sia ormai consolidata la tendenza a svalutare integralmente il credito, già nell’esercizio di apertura della del fallimento o della liquidazione giudiziale. Tale condotta pare influenzata dalla previsione di deducibilità immediata prevista dalla disciplina sul reddito d’impresa (art. 101, co. 5, del D.P.R. 917/1986), oltre che dalla facoltà di emissione della nota di variazione IVA già all’avvio della procedura, a norma del predetto art. 26, co. 3-bis, lett. a), del D.P.R. 633/1972. Sul punto, si osserva che nell’esercizio di avvio del fallimento o della liquidazione giudiziale potrebbero non sussistere, oggettivamente, elementi adeguati per svalutare puntualmente il credito, in quanto è necessario conoscere due elementi fondamentali: il passivo e l’attivo del fallimento.
Sotto il primo profilo, si segnala che il passivo della procedura non comprende necessariamente tutti i creditori originari del fallimento o della liquidazione giudiziale, ma soltanto quelli che hanno presentato la relativa domanda, accolta in sede di accertamento del passivo, ovvero di verifica delle domande di ammissione presentate dai creditori: questa fase non si conclude in tempi brevi, e certamente non nell’esercizio di apertura della procedura, in quanto – oltre all’esame delle istanze tempestive, previste in un’udienza da tenersi entro 120 giorni dalla sentenza dichiarativa di apertura della procedura (artt. 16, co. 1, n. 4), del RD 267/1942, e 49, co. 3, lett. d), del D.Lgs. 14/2019) – è riconosciuto un periodo di tempo per il deposito delle “domande tardive” (un anno nel fallimento, a norma dell’art. 101, co. 1, L.fall., e sei mesi nella liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 208, co. 1, del D.Lgs. 14/2019). Conseguentemente, nell’esercizio di apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale, il creditore non è in grado di sapere quali e quanti creditori abbiano diritto ad un soddisfacimento preferenziale rispetto al proprio.
Per quanto concerne, invece, la valutazione del secondo elemento rilevante per la stima della presumibile possibilità di soddisfazione del credito, si consideri che l’attivo del fallimento o della liquidazione giudiziale non si compone esclusivamente di crediti e beni – il cui inventario può, in ogni caso, richiedere tempi lunghi, come nel caso delle imprese di costruzione, aventi diversi cantieri – ma anche delle azioni legali di responsabilità (artt. 146 L.fall. e 255 del D.Lgs. 14/2019) e revocatorie (artt. 67 L.fall., 166 del D.Lgs. 14/2019 e 2901 c.c. ), che possono consentire al fallimento o alla liquidazione giudiziale di acquisire rilevanti risorse da destinare alla soddisfazione dei creditori: tali informazioni non sono naturalmente note nell’esercizio di apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale, e spesso neanche nel successivo, con l’effetto che, in questi periodi amministrativi, qualsiasi svalutazione del credito potrebbe risultare fondata su considerazioni meramente approssimative e superficiali, e talvolta non rispondenti alla principale prova documentale direttamente acquisibile, ovvero il rapporto riepilogativo che il curatore fallimentare è tenuto a redigere ogni sei mesi (artt. 33, co. 5, L.fall. e 130, co. 9, del D.Lgs. 14/2019). Si tratta dell’atto nel quale sono esposte le predette informazioni in ordine all’attivo – sia realizzato che potenziale – e al passivo, nonché quelle riguardanti le presumibili possibilità di soddisfazione delle diverse classi di creditori (privilegiati, chirografari, ecc.).